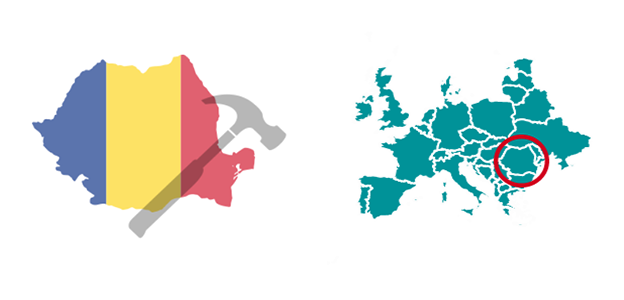Schiavi del cemento
Quando si parla di caporalato, vengono in mente i pomodori di Rosarno.
Ma lo sfruttamento del lavoro non esiste solo al Sud e nell’agricoltura. È anche a Milano, nell’edilizia
Schiavi del cemento
di Andrea Boeris e Mattia Guastafierro
 bdelhadi aveva 27 anni e una vita davanti quando in un pomeriggio di settembre, dall’impalcatura del palazzo di quattro piani dove stava lavorando, è precipitato al suolo. Era egiziano, ma si guadagnava da vivere a Milano come muratore. Nessuno si era mai accorto di lui. Non aveva i documenti in regola. Per lo Stato era un fantasma. Per la società un marginale. Un uomo invisibile che si è materializzato solo quando quella maledetta impalcatura in via Mangone, a due passi dalla Darsena, ha ceduto strappandolo alla sua famiglia.
bdelhadi aveva 27 anni e una vita davanti quando in un pomeriggio di settembre, dall’impalcatura del palazzo di quattro piani dove stava lavorando, è precipitato al suolo. Era egiziano, ma si guadagnava da vivere a Milano come muratore. Nessuno si era mai accorto di lui. Non aveva i documenti in regola. Per lo Stato era un fantasma. Per la società un marginale. Un uomo invisibile che si è materializzato solo quando quella maledetta impalcatura in via Mangone, a due passi dalla Darsena, ha ceduto strappandolo alla sua famiglia.
Quando le forze dell’ordine arrivano sul posto non riescono nemmeno a identificarlo. I pochi colleghi che aveva rimangono in silenzio. Hanno paura. Temono per il loro futuro. Ci vorranno cinque giorni per dare un nome a quel ragazzo, reclutato al cantiere soltanto poche ore prima.
Abdelhadi Seif Nasr Wael è una delle vittime del caporalato edilizio. Della schiavitù di cui si sente parlare solo al sud, quando l’estate centinaia di braccianti raccolgono i pomodori che finiscono sulle nostre tavole. Ma il caporalato s’è fatto largo pure al nord, tra la calce e la pala. Ha contagiato la Milano dei grattacieli all’avanguardia, dove recluta i disperati all’alba, nei piazzali. Oppure tramite un messaggio su Whatsapp. «Domani alle 7 al cantiere». E via, verso una nuova giornata di lavoro.
Difficile dare numeri sul fenomeno, perché chi ne è vittima quasi mai lo denuncia. Qualche coraggioso comincia a farsi avanti. Come Said, Ivan e Dimitri. Nomi di fantasia, anche loro una volta fantasmi. E ora persone che non vogliono più essere braccia senza nome e che hanno deciso di raccontare la loro storia.
Caporalato: forma illegale di reclutamento della manodopera attraverso intermediari (caporali) che assumono operai, per conto dell’imprenditore e percependo una tangente, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali.
Furgoni, legno e vernice
 «Gli egiziani, si sa, sono i migliori nel ferro e nel legno». Come Said, carpentiere per una importante azienda energetica italiana. In cantiere ci arriva con il furgone del caporale. L'appuntamento ogni mattina all'alba, tra San Siro e via Lorenteggio.
«Gli egiziani, si sa, sono i migliori nel ferro e nel legno». Come Said, carpentiere per una importante azienda energetica italiana. In cantiere ci arriva con il furgone del caporale. L'appuntamento ogni mattina all'alba, tra San Siro e via Lorenteggio.Said, Egitto - Ferraiolo, carpentiere e imbianchino
Sigarette e cartongesso
 Zio e nipote, rumeni, una vita a lavorare il cartongesso. Come tanti connazionali, sulle impalcature dei cantieri di Milano. Piazza Duomo o Repubblica. A 50 metri di altezza, senza misure di sicurezza. Là dove tremano i polsi e la voce si spezza.
Zio e nipote, rumeni, una vita a lavorare il cartongesso. Come tanti connazionali, sulle impalcature dei cantieri di Milano. Piazza Duomo o Repubblica. A 50 metri di altezza, senza misure di sicurezza. Là dove tremano i polsi e la voce si spezza.Ivan e Dimitri, Romania - Cartongessisti
Furgoni, legno e vernice
Said, Egitto – Ferraiolo, carpentiere e imbianchino
 aid arriva in ritardo, in tenuta da lavoro. Dopo una giornata in cantiere, aveva un’ultima faccenda da sbrigare. Le sue mani ruvide sono ancora sporche di grasso e vernice bianca. O forse, lo sono sempre state. Difficile togliere la pittura dalla pelle di un imbianchino, ogni giorno al lavoro tra secchi e pennelli. Non è però sempre stato questo il suo mestiere. «Noi egiziani, si sa, siamo i migliori nel ferro e nel legno», racconta nel suo italiano zoppicante. «Un po’ per tradizione, un po’ per cultura, i più esperti nel campo», conferma Khalid Bouzyan, sindacalista della Fillea Cgil. Prima di prendere in mano spatola e pennello, Said si guadagnava da vivere come ferraiolo e carpentiere. A Milano e fuori. Le recinzioni dei cantieri gli unici suoi posti di lavoro, da quando ha messo piede in Italia.
aid arriva in ritardo, in tenuta da lavoro. Dopo una giornata in cantiere, aveva un’ultima faccenda da sbrigare. Le sue mani ruvide sono ancora sporche di grasso e vernice bianca. O forse, lo sono sempre state. Difficile togliere la pittura dalla pelle di un imbianchino, ogni giorno al lavoro tra secchi e pennelli. Non è però sempre stato questo il suo mestiere. «Noi egiziani, si sa, siamo i migliori nel ferro e nel legno», racconta nel suo italiano zoppicante. «Un po’ per tradizione, un po’ per cultura, i più esperti nel campo», conferma Khalid Bouzyan, sindacalista della Fillea Cgil. Prima di prendere in mano spatola e pennello, Said si guadagnava da vivere come ferraiolo e carpentiere. A Milano e fuori. Le recinzioni dei cantieri gli unici suoi posti di lavoro, da quando ha messo piede in Italia.
Ha lasciato il suo paesino a 190 chilometri da Il Cairo ad appena 16 anni. Ha attraversato il deserto arrivando in Libia. Poi il Mediterraneo con un gommone, insieme a quei migranti che già nei primi anni ’90 iniziano a prendere il mare. È sbarcato in Sicilia, forse a Lampedusa. Non ricorda più dove. Poi ha sempre vissuto a Milano, lungo i viali della circonvallazione. Da allora sono passati 14 anni. Nel frattempo Said, oggi poco più che trentenne, ne ha visti centinaia di cantieri. Una vita dedicata al lavoro, quello nero. Senza contratto, senza tutele, senza diritti. Senza mai riuscire a tornare in Egitto, perché solo chi ha un’occupazione regolare può richiedere il permesso di soggiorno e viaggiare. Un requisito che conosce bene chi, con la promessa di una vita in regola, sfrutta gli schiavi del cemento.
«Ho fatto di tutto nei cantieri. ”Vuoi il permesso di soggiorno? Vuoi tornare in Egitto?”, mi dicevano. “Tu lavori e fai quello che ti dico io”».
Said, EgittoIl momento più buio a maggio 2016. «Quando lavoravo per quell’impresa lì», risponde subito, rivolgendosi con un cenno a Bouzyan che lo assiste da quando si è rivolto al sindacato. Ricorda di quando il fratello di un amico, egiziano come lui, lo ha reclutato per un posto da carpentiere. Ne serviva uno per una società che aveva ottenuto un appalto da una grande azienda energetica. Bisognava lavorare in tre cantieri del Nord Italia: a Sannazzaro in provincia di Pavia, a Spinetta frazione di Alessandria e a Venezia. Nel mondo dell’edilizia la filiera degli appalti a “scatole cinesi” è un fenomeno noto. Un lecito ma intricato labirinto di imprese edili, dove il caporalato e lo sfruttamento della manodopera trovano terreno fertile. Come accade a Said.
«Ogni giorno alle 6 del mattino mi presentavo in via Lorenteggio e il sabato in San Siro», racconta. I luoghi di cui parla sono solo due snodi del caporalato milanese, ma se ne potrebbero citare molti altri. Ad attendere lui e altri operai, con la macchina in moto, sempre lo stesso egiziano che l’aveva agganciato. Il caporale, pronto a partire alla volta dei cantieri della provincia.
La paga sempre 100, 150, 200 euro. In contanti e in anticipo sul mese. Cifre lontane da quelle che secondo il contratto collettivo dell’edilizia spetterebbero a un operaio di primo livello (il meno specializzato). E ben diverse da quelle scritte sulla busta paga che ogni mese veniva emessa a suo nome, senza che lui mai la ricevesse. «Per precauzione dell’azienda, Said risultava regolarmente assunto. Peccato che non abbia mai firmato nulla. Qualcun altro deve averlo fatto al suo posto», ipotizza il sindacalista Bouzyan. «Nel frattempo veniva pagato in nero e molto meno di quanto dovesse ricevere», cioè 2.107 euro netti al mese. Lo si legge sul documento che il sindacato è riuscito a recuperare. Sulle misure di sicurezza non si scherzava: «All’interno del cantiere venivano sempre rispettate tutte le norme», spiega. Ma se si verificavano incidenti la storia cambiava.
«Un giorno è caduta una sega circolare sulla schiena di un mio compagno. È stato tre mesi in ospedale, ma nessuno ha mai detto nulla. Mentre lui era via, ci hanno dato il suo cartellino: dovevamo timbrarlo al suo posto ogni mattina».
Said, Egitto«Quando ha deciso di interrompere i rapporti, l’azienda doveva a Said circa 16.000 euro», conclude Bouzyan. «Abbiamo intrapreso una conciliazione e siamo riusciti a recuperarne la metà. Dopodiché la società si è sciolta e ricostituita, modificando il nome per far perdere le tracce. Sarà difficile ora ottenere il resto di quanto gli spetta».
Cartongesso e sigarette
Ivan e Dimitri, Romania – Cartongessisti
 gni giorno ti svegli alle 5 di mattina, prendi il treno e vai a lavorare. Per 10, 12 ore. Torni a casa, mangi e poi? Quando puoi dormire?». Dalla bocca di Ivan esce una zaffata di fumo. Il pacchetto di sigarette è ormai vuoto. Sono passate due ore, ma la frustrazione rimane. Ogni volta che ripensa alla sua storia la collera sale.
gni giorno ti svegli alle 5 di mattina, prendi il treno e vai a lavorare. Per 10, 12 ore. Torni a casa, mangi e poi? Quando puoi dormire?». Dalla bocca di Ivan esce una zaffata di fumo. Il pacchetto di sigarette è ormai vuoto. Sono passate due ore, ma la frustrazione rimane. Ogni volta che ripensa alla sua storia la collera sale.
«Succede solo a noi rumeni. Gli italiani invece fanno 8 ore e poi a casa». Anche Dimitri pensa lo stesso. Il loro è un grido di rabbia: sono stanchi delle condizioni in cui sono costretti a lavorare gli stranieri nei cantieri italiani. E perché nessuno si ribella?
«Perché non conviene. “Se non ti sta bene, vai a casa”, ci dicono. E noi non possiamo permetterci di perdere il lavoro, quando devi mangiare, pagare l’affitto e le bollette».
Ivan, RomaniaIvan e Dimitri sono zio e nipote. Rumeni e cartongessisti. I migliori nel tirare su pareti e soffitti «in pochissimo tempo», assicura Dimitri. «Ho sempre fatto questo mestiere, da prima che venissi in Italia», racconta Ivan. Ha quasi 60 anni, il fisico robusto e allenato dai pesi che ogni giorno è abituato a portare. Dimitri è più esile, ha circa 35 anni e le sue mani sono ricoperte di cicatrici.
«Mi sono trasferito a Milano nel 2005, quando mia moglie ha trovato lavoro come badante», dice Ivan. Suo nipote aveva lasciato la Romania già tre anni prima: un passaggio in Francia e poi l’arrivo in Italia. Una volta in città non è stato difficile per loro darsi da fare come operai. In 15 anni, di cantiere in cantiere, hanno girato la Lombardia e non solo: Brescia, Bergamo, Como, Lodi, Piacenza. Sempre all’opera, vicino casa o in trasferta. Il lavoro come ragione economica e ragione sociale. «In nero o in regola, l’importante è lavorare. E se riesci a prendere il permesso di soggiorno, sei fortunato», dice Dimitri. Come lui e suo zio, in regola quasi da subito.
Nel migliore dei casi Ivan e Dimitri venivano assunti per “distacco”. Un’operazione che consente alle aziende italiane di ingaggiare il personale di una ditta estera (e quasi sempre fondata ad hoc) con contratti stranieri, spesso rumeni. Uno stratagemma semplice (e lecito) per pagare il lavoro di muratori in trasferta (ma a tutti gli effetti residenti in Italia) secondo standard più bassi: 300 euro contro 1000, a parità di livello. «Quando succede, ti va bene», racconta Dimitri. Ma non sempre accade.
«Come quando abbiamo lavorato per quel bastardo», esclama Ivan. Lo ripete più volte, quasi a esorcizzare l’amarezza. Il «bastardo» è un caporale rumeno. «Lo conoscevamo perché ci aveva affittato casa, appena arrivati in Italia». A lui zio e nipote hanno prestato le braccia in grandi cantieri. In piazza Duomo ad esempio, ma soprattutto a Repubblica.
Il caso risale all’estate del 2016. Nell’esclusivo quartiere vicino a Porta Venezia, nascosti tra parchi, hotel e ambasciate, «eravamo tutti in nero», sorride amaro Ivan. Su 90 operai solo 10, 15 al massimo erano in regola. «Di un contratto neanche l’ombra», conferma Dimitri. Al punto che non capitava raramente che l’ispettorato del lavoro facesse qualche visita. «Quando arrivava la sicurezza, il caporale ci telefonava e ci diceva: “Via, via, fuori dal cantiere!”. Noi uscivamo e aspettavamo al bar o in strada, anche fino a sera. Se perdevamo la giornata, non venivamo pagati», spiega Ivan.
Ogni mattina, all’ingresso, il caporale requisiva le carte d’identità. In cambio consegnava un cartellino: bianco, senza nome e senza foto. Un badge fantasma che apparteneva un giorno a un operaio, quello dopo a un altro. Dopo quattro mesi di lavoro non retribuito dentro lo scheletro di quel palazzo da venti piani, zio e nipote hanno detto basta. Troppo pochi 2.000 euro in due per rischiare la vita a 50 metri d’altezza. Senza casco e imbracatura, là dove ti tremano i polsi e ti si spezza la voce. «Ce ne doveva quattro volte tanto!», quasi grida Ivan. A loro due e ad almeno altri 15 muratori che nel cantiere di Repubblica erano al suo soldo.
«Per convincerci a lavorare ci scriveva: “Vieni, vieni a lavoro domani che ti do i soldi”. Non li abbiamo mai visti. Con le nostre paghe ha rubato 160mila euro. E mentre noi lavoravamo, lui andava in giro sulla sua bella macchina, coi suoi bei vestiti, vantandosi con tutti».
Dimitri, RomaniaDopo due ore di racconto parole e sigarette sono finite. La delusione lascia per un momento spazio alla malinconia: «L’Italia è un Paese bello», dicono. Permette a tanti stranieri di lavorare e mettere da parte quel poco che in patria vale molto. «In Romania non riesci neanche a fare la spesa: carne e verdura costano troppo. Non hai altra scelta se non partire…», spiega Dimitri. Le loro speranze però non sono cambiate: «Sogno di tornare dove sono nato e costruire lì la mia casa», dice Ivan. «Non manca molto: solo due anni. Poi andrò in pensione e potrò finalmente tornare».
 e indagini sulla morte di Abdelhadi sono ancora in corso. Se ne sta occupando la Procura di Milano. I giornali hanno parlato di lui nei giorni immediatamente successivi all’incidente, finché il suo corpo non è stato identificato. A mesi di distanza da quel pomeriggio di settembre, di lui si sa ancora poco: non si conosce il suo passato, se avesse una moglie e dei figli. Tantomeno è possibile stabilire chi siano i responsabili della sua morte.
e indagini sulla morte di Abdelhadi sono ancora in corso. Se ne sta occupando la Procura di Milano. I giornali hanno parlato di lui nei giorni immediatamente successivi all’incidente, finché il suo corpo non è stato identificato. A mesi di distanza da quel pomeriggio di settembre, di lui si sa ancora poco: non si conosce il suo passato, se avesse una moglie e dei figli. Tantomeno è possibile stabilire chi siano i responsabili della sua morte.
Come un’ombra Abdelhadi ha attraversato i cantieri di Milano e come un’ombra se n’è andato. Le storie di Said, Ivan e Dimitri sono per lui.