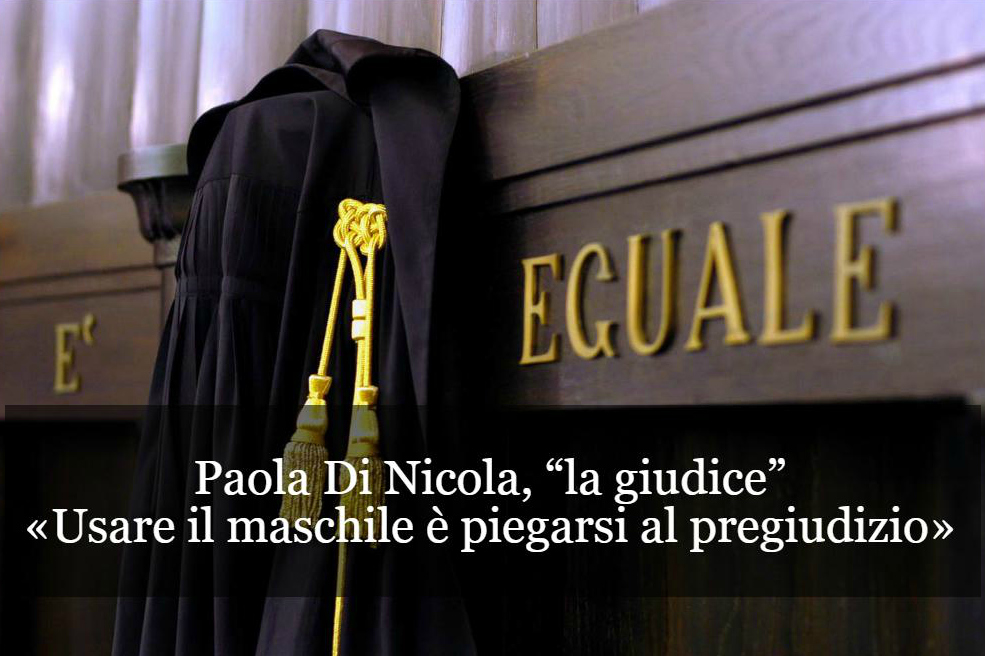
Da oltre vent’anni in magistratura, ha scritto un libro contro il sessismo della toga. Ma ancora «nessun altro mi chiama così»

«Per vent’anni mi sono firmata “il giudice”, poi la miccia si è accesa nel 2009 durante un interrogatorio a un imputato per criminalità organizzata nel carcere di Poggio Reale». Paola Di Nicola è nata nel 1966 a Offida (Ascoli Piceno) ed è entrata in magistratura nel 1994. Nel 2012 ha scritto il libro “La giudice” (ed. 881) sulla questione della differenza di genere in tribunale. «Nel corso di quell’interrogatorio ho avuto la percezione chiara e netta che il mio ruolo non fosse riconosciuto dall’indagato: non mi vedeva come una giudice, ma come una donna, anzi una femmina», ricorda. «Il suo sguardo disturbante percorreva il mio corpo, una brutta esperienza che molte donne hanno vissuto. Sicuramente mi sarà capitato anche in passato, ma non me ne ero mai accorta. Da quel momento in poi ho cercato di capire il perché».
Così è nato il suo testo, che in 176 pagine cerca di cambiare la concezione che si ha delle toghe al femminile. «Quando sono entrata in magistratura pensavo che non ci fossero differenze», dice. E invece «ciò che è maschile è riconosciuto, riconoscibile e ha valore. Ciò che è donna no. Ho scavato nella storia della magistratura e ho riflettuto sul fatto che fino a 50 anni fa le donne neanche ci potevano entrare, perché è il luogo istituzionale più rappresentativo del potere, dal momento che si prendono decisioni sui diritti delle altre persone. E il potere, tradizionalmente, è degli uomini».
Prima di iniziare a firmarsi al femminile, la giudice Paola Di Nicola ha fatto un esperimento: «Ho chiamato il mio compagno, anche lui magistrato, e gli ho chiesto come avrebbe reagito se gli fosse stato imposto di firmarsi “la giudice”. E mi ha risposto “Stai bene? Denuncerei tutti, non lo permetterei mai”. Ecco: allora perché noi donne ce lo auto-infliggiamo? E chi dovremmo denunciare poi, noi stesse?». Da qui la sua battaglia, un gesto di «consapevolezza» sulle orme della presidente della Camera Laura Boldrini: «Farsi chiamare al maschile equivale a piegarsi al pregiudizio. Se l’italiano permette l’uso del femminile, bisogna usarlo. Se nella lingua esiste solo ciò che viene nominato, le donne è come se non esistessero».
Ma come sta andando la sua missione? «Io mi firmo “la giudice”, ma nessun altro mi chiama ancora così. Forse solo due o tre avvocati su migliaia. E alcune colleghe mi hanno detto che vedono la differenziazione non necessaria, anzi: una forma di protagonismo. “L’istituzione è unica, si vede che siamo donne, quello che conta sono i nostri provvedimenti”, sostengono. Sono d’accordo sul ragionamento, ma bisogna anche cambiare la lingua. Una cosa non esclude l’altra. E anche se ci vorrà molto tempo, sono sicura che prima o poi questa consapevolezza ce l’avranno tutte le donne italiane».


